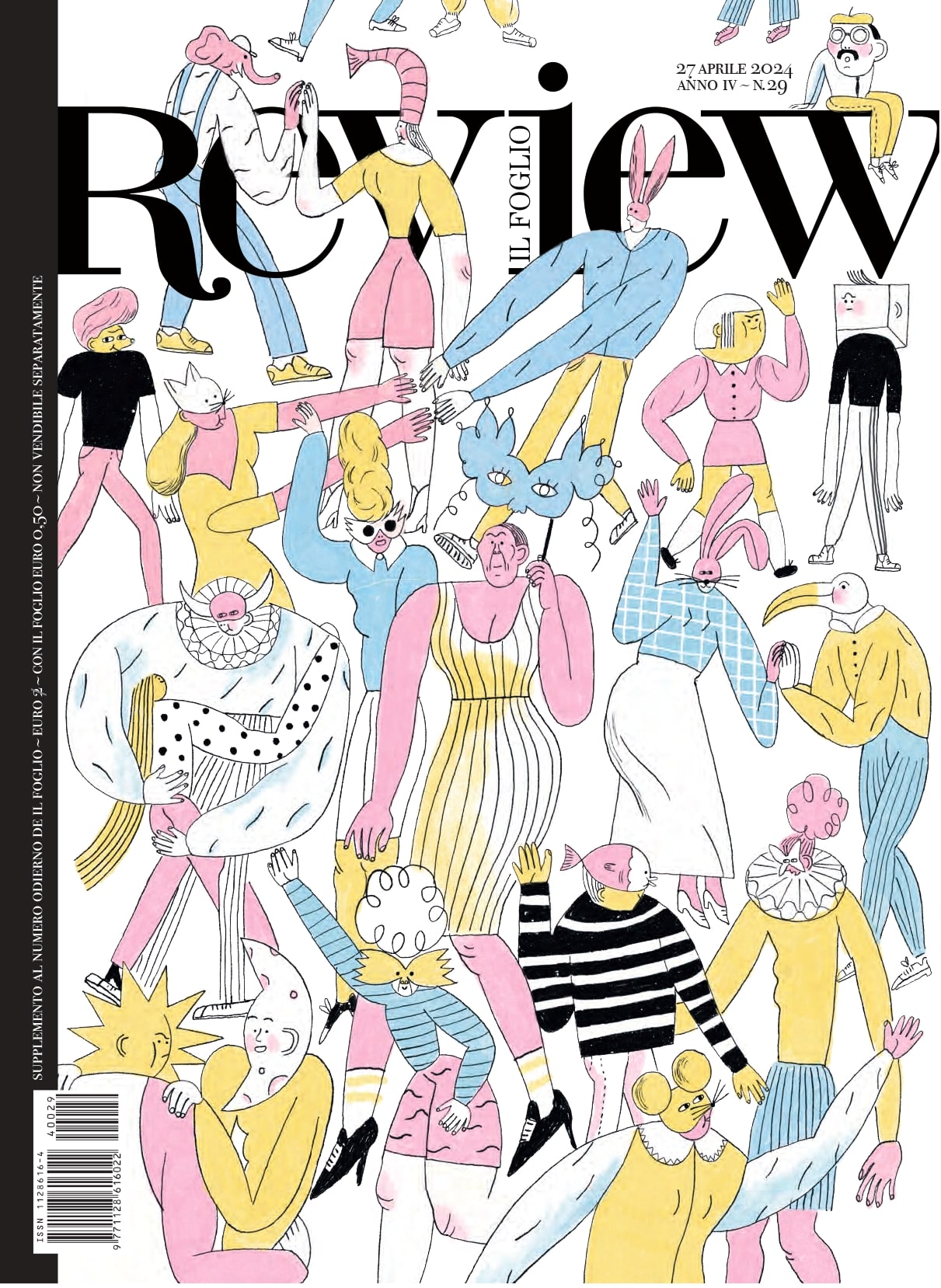L’universo si sta dilatando. Un bel giorno scoppierà, e sarà la fine di tutto. Il piccolo Alvy Singer lo ha letto da qualche parte ed è caduto in depressione. Ha anche smesso di fare i compiti: che senso avrebbe? Meno male che la mamma, che ha il piglio pragmatico e autoritario della yiddishe mame, lo riporta bruscamente alla realtà: l’universo si sta dilatando, d’accordo, ma questo cosa c’entra con la scuola? E poi, dico, sono affari tuoi? Tu vivi a Brooklyn, e Brooklyn non si sta dilatando. Anche il dottore prova a dare uno scossone gioviale al piccolo esistenzialista che fissa il vuoto dietro i suoi occhialoni dalla montatura sproporzionata: mentre l’universo si espande, gli dice, noi quaggiù dobbiamo cercare di spassarcela. La cura sbrigativa non funziona, e Alvy resterà nevrotico a vita; ma almeno si dispererà per le donne, non per la cosmologia. È già qualcosa.
Se Io e Annie di Woody Allen fosse scritto oggi, probabilmente quella scena sarebbe tutta diversa. La mamma metterebbe le angosce pascaliane di Alvy in cima alle sue preoccupazioni, e consulterebbe terapeuti di tutte le scuole pur di fargli superare il trauma del Big Bang e proteggerlo dalla sua ansia da radiazioni cosmiche; e qualche psicologo particolarmente empatico e compassionevole spiegherebbe al bambino che la sua depressione astrofisica è perfettamente giustificata, e che gli adulti – a partire dal terapeuta stesso e dalla mamma apprensiva – hanno l’obbligo morale di abbracciarla, di farla propria. Che sia lui, Alvy, a far loro da guida, a illuminarli sul corretto sentimento da tenere nei confronti del mondo! Sarebbe, lo riconosco, una scena pedestre, roba da chiedere il rimborso del biglietto al botteghino, però ha un vantaggio tutt’altro che trascurabile: questo remake non c’è bisogno di scriverlo e di girarlo, è già in cartellone in buona parte del mondo occidentale. Oggi infatti esistono psicologi che curano specificamente la climate anxiety. I ragazzini che si rivolgono a loro non si sentono depressi perché l’universo si sta dilatando, semmai perché il pianeta si sta riscaldando. E spesso, come Alvy, non riescono ad andare a scuola per l’ansia da gas serra. L’americana Karla Vermeulen, specializzata in disaster mental health, è la più rinomata esponente di questo filone terapeutico, e addestra altri psicologi che vogliono adottarlo. Ha scritto anche un libro, Generation Disaster, il cui titolo non allude, come qualcuno potrebbe pensare, al disastro psicologico dell’ultima generazione – che le sembra invece sanissima – ma al disastro generale del mondo, rispetto al quale la depressione è una risposta del tutto razionale. La climate-aware therapy parte appunto da questo postulato: dobbiamo sposare la disperazione dei bambini e degli adolescenti circa i destini del pianeta.
A raccontare tutto questo è la giornalista investigativa Abigail Shrier in un libro pubblicato poche settimane fa, Bad Therapy (è il suo secondo, dopo il famoso o famigerato Irreversible Damage, il libro del 2020 sulla questione della transizione ormonale e chirurgica dei minorenni che le attirò grandi elogi e violenti boicottaggi). Shrier, ebrea statunitense e madre di tre figli, non esita qui a sfoggiare lo stile imperioso della yiddishe mame, che la sua mamma e la sua nonna hanno adottato con lei e che lei si rammarica di non aver saputo adottare con i propri bambini. Il pianeta si sta riscaldando, su questo non ci piove; ma nel 1962, dice Shrier, i bambini avevano angosce altrettanto fondate per l’apocalisse nucleare che sembrava imminente, eppure questo non li portò a tassi insoliti di assenze scolastiche, e soprattutto non ispirò la proposta di includere la nuclear anxiety tra i disturbi psicologici riconosciuti. La seconda osservazione è più importante della prima. La tesi del libro, infatti, è che in molti casi è proprio la psicoterapia a creare il problema: la cosiddetta iatrogenesi, quando una patologia è causata dalla cura o dal farmaco. Un luogo comune ricorrente -«tutti dovremmo andare in terapia, male non farà» – è messo sotto processo quasi in ogni pagina. Camilo Ortiz, uno psicologo dell’infanzia e dell’adolescenza di origini colombiane, non è d’accordo (e forse non è un caso che buona parte degli specialisti intervistati da Shrier provenga da paesi in cui la vita è ben più feroce che negli Stati Uniti). Nessun chirurgo, dice Ortiz, ragionerebbe così: «Il paziente sembra sano, ma nel dubbio apriamolo e vediamo un po’ cosa troviamo». Magari qualcosa alla fine si trova, frugando con il bisturi, ma a che costo? La tesi di Bad Therapy – l’autrice lo mette in chiaro nella prima pagina – non riguarda i casi di problemi mentali gravi e conclamati, ma solo i bambini e gli adolescenti che si sentono ansiosi, insicuri, preoccupati, spaventati, tristi, a disagio – malesseri spesso vaghi e indefiniti a cui genitori, insegnanti e assistenti sociali danno una risposta univoca, la psicoterapia. Che può fare molto bene, certo, ma per le stesse ragioni può fare anche molto male. Shrier elenca i dieci comandamenti della cattiva terapia, e forse vale la pena riportarli: primo, insegna ai bambini a prestare grande attenzione ai propri stati d’animo; secondo, induci la ruminazione; terzo, fai della felicità un obiettivo ma ricompensa la sofferenza emotiva; quarto, afferma e soddisfa tutte le preoccupazioni dei bambini; quinto, monitorali ossessivamente; sesto, distribuisci generosamente etichette diagnostiche; settimo, imbottiscili di farmaci; ottavo, incoraggia i bambini a condividere il loro «trauma»; nono, incoraggia i ragazzi a rompere i contatti con le famiglie «tossiche»; decimo, crea dipendenza dal trattamento. Se i dodici passi degli alcolisti anonimi culminano con la liberazione dalla dipendenza, i dieci passi della cattiva terapia la creano. Ciononostante, molti di questi imperativi sono diventati senso comune nelle famiglie, nelle scuole, nelle università, nella gestione delle risorse umane. Una volta compiuto il primo errore – promuovere la concentrazione ossessiva sul proprio stato interiore, che è come prendersi da soli la temperatura ogni cinque minuti per togliersi il dubbio di avere la febbre – è difficile non compiere anche gli altri nove.
Non è la prima volta che questo allarme viene lanciato. Aveva cominciato lo psicoanalista e sociologo Philip Rieff – il marito di Susan Sontag – in un libro profetico del 1966, The Triumph of the Therapeutic, che annunciava il trionfo dell’«uomo psicologico» e, con esso, l’avvio di una morbida apocalisse culturale. Se l’uomo religioso aspira a essere salvato, scriveva Rieff, l’uomo psicologico vuol essere gratificato; al motto ascetico del primo – «Io credo» – si sostituisce ormai il caveat del secondo – «mi sento così» – che trova nello psicoterapeuta «la sua guida spirituale secolare». Dopo Rieff è toccato a Christopher Lasch, con il suo classico del 1979 La cultura del narcisismo, e poi, in anni più vicini ai nostri, al sociologo Frank Furedi (Therapy Culture, 2003), alla filosofa femminista Christina Hoff Sommers e alla psichiatra Sally Satel (One Nation under Therapy, 2005), allo psicologo morale Jonathan Haidt e all’avvocato Greg Lukianoff (The Coddling of the American Mind, 2018). Mettendoli in fila si ha l’impressione di leggere la cronistoria di un’invasione, una lunga marcia in cui la mentalità terapeutica ha occupato una dopo l’altra tutte le roccaforti del potere simbolico e ideologico. L’epoca vaticinata da Rieff, in cui il prete-psicologo accorpa in sé le due funzioni del burocrate e del consigliere spirituale, potrebbe infine essere arrivata. Bad Therapy non è certo il migliore, in questa compagnia bibliografica – anzi è possibile che sia il più schematico, per il suo buon senso un po’ sempliciotto – ma è quello che offre la documentazione più aggiornata per constatare l’avanzamento dell’epidemia terapeutica. Per tutte le comuni difficoltà della vita – un trasloco, una delusione d’amore, l’ansia per gli esami – è approntata un’etichetta diagnostica, che spesso sembra inventata da Molière: il disagio di ritrovarsi in una nuova città e in una nuova scuola prende il nome tecnico di relocation depression; la nostalgia per i compagni di classe durante la pausa estiva diventa summer anxiety; il bambino timido scopre di essere affetto in realtà da social anxiety disorder; quello indisciplinato, invece, ha i chiari segni di un oppositional defiant disorder; e soprattutto, pressoché ogni cosa può diventare un «trauma» – altra parola che avanza senza pietà annettendosi tutto, come Gengis Khan, in un instancabile imperialismo semantico – e ogni trauma inconsapevole dev’essere dissotterrato con strumenti di auscultazione raffinatissimi, perché si possa esorcizzare il passato e andare avanti.
Quando questa filosofia è adottata dalle istituzioni educative, il rischio è di creare in serie esemplari dell’«uomo psicologico» di Rieff, del «narcisista» di Lasch, del «sé diminuito» di Furedi, della personalità fragile «destinata al fallimento» di Haidt e Lukianoff, dell’individuo «emotivamente sottosviluppato» di Hoff Sommers e Satel. La diagnosi è sempre la stessa: stiamo creando in vitro, e con le migliori intenzioni, persone incapaci di affrontare la vita. Ma siccome la specie umana è zuccona, deve sbattere la testa molte e molte volte contro il muro dell’evidenza prima di risolversi a cambiare direzione. La vicenda di Will Hunting di Gus Van Sant, dice Shrier, funziona bene a Hollywood ma un po’ peggio nella realtà. In quel film Matt Damon ripercorreva una storia terribile di abusi infantili aiutato dal suo terapeuta, Robin Williams, e solo grazie a questa anamnesi poteva liberarsi dal trauma. Non sono certo che l’esempio sia ben scelto. Io dico piuttosto che faremmo bene a riflettere su un altro film, Carnage di Roman Polanski, tratto dal Dio dei massacri di Yasmina Reza, dove un banalissimo bisticcio tra ragazzini, risolto dagli stessi in quattro e quattr’otto senza troppi drammi, viene sviscerato e ingigantito dai genitori fino a portarli a un passo dalla carneficina. La nuova generazione ha molti problemi e fonti di ansia, è vero. Uno è il cambiamento climatico. Un altro sono gli adulti.