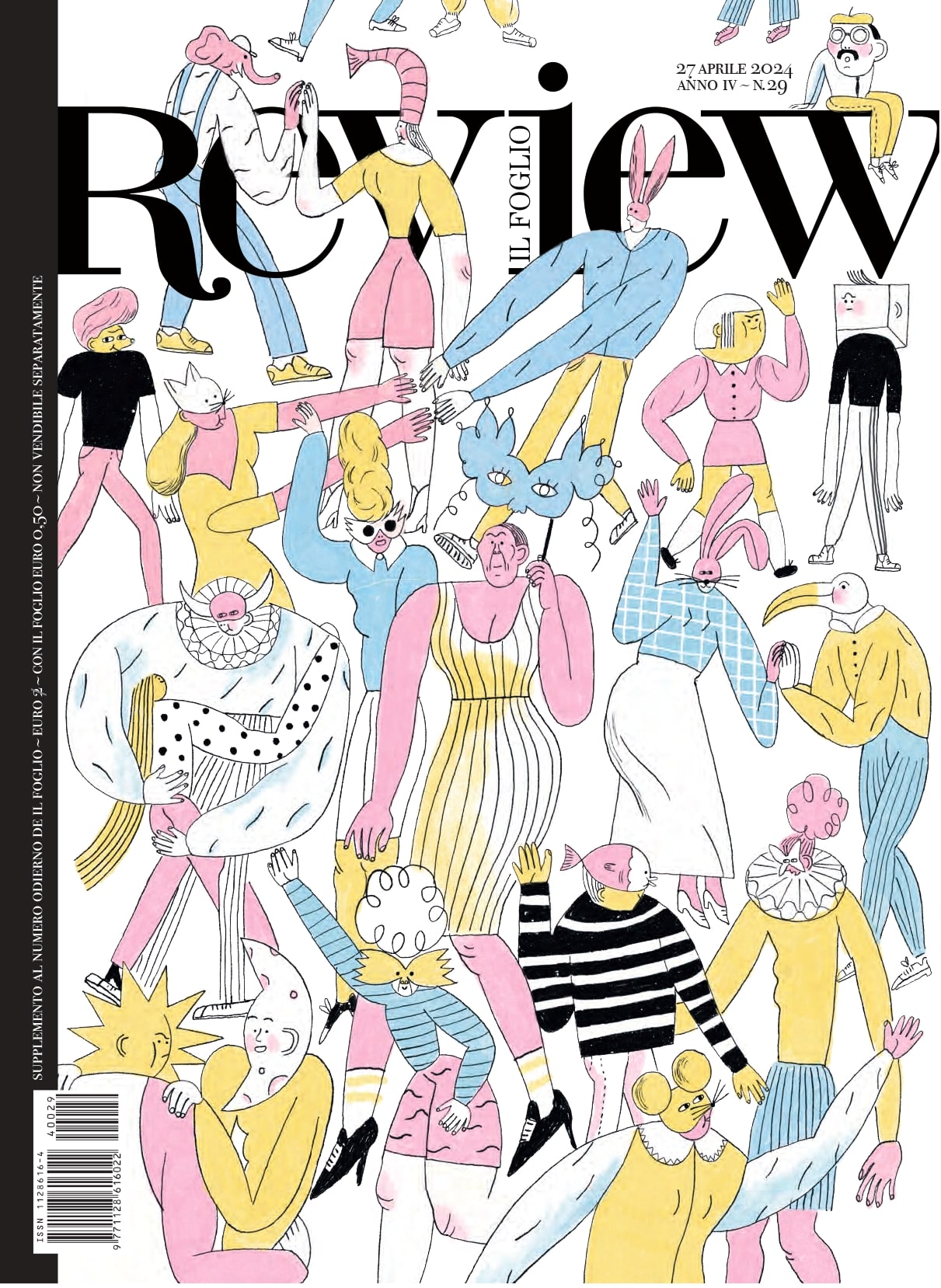Questa è una storia d’amore, di crimine e di rivoluzione». È il titolo di una storia che si è conclusa, ed è iniziata, nell’estate di cento anni fa. Una di quelle storie che s’intrecciano l’un l’altra componendo una trama che alimenta il mito di un mondo esotico e al tempo stesso rappresenta il cambiamento di quel mondo e del nostro.
È una storia che ha per protagonisti André Malraux, «scrittore, razziatore, combattente per la libertà, uomo di stato» e Clara Goldschmidt, la sua «moglie femminista», definita così più per anticonformismo che rivendicazioni di genere. Oltre a loro una serie di personaggi, archeologi, studiosi, idealisti, scrittori, artisti, intellettuali, rivoluzionari, che animano la Francia degli années folles. Come tante storie di quegli anni, anche questa inizia al porto di Marsiglia, là dove prendevano il largo les écrivains physiques – Mac Orlan, Rimbaud, Cendrars – scrittori accomunati dal tema dell’avventura come modello esistenziale e ispirazione letteraria. Il 13 ottobre 1923 il ventiduenne André Malraux, appena uscito dall’École des Langues Orientales, accompagnato dalla moglie Clara, 25, e dal compagno di studi Louis Chevasson, s’imbarca sul bastimento Angkor alla volta della Cambogia. Nelle sue memorie Clara racconta il piano di André. «Eh bien, andiamo in questo piccolo tempio, preleviamo qualche statua e la vendiamo in America. Così potremo vivere tranquilli per due o tre anni». Ricca ereditiera di famiglia ebraica, nonostante André avesse già dilapidato la sua dote con investimenti azzardati, Clara era disposta a tutto per assecondarlo. Senza contare che la follia stessa di quel progetto la tentava. Scrive Dominique Bona nella biografia Clara Malraux: «Voleva dimostrarsi una degna compagna. Al diavolo la morale borghese e la prudenza che ne consegue! Clara sarebbe partita, avrebbe accompagnato Malraux. Per lei contava solo questo: vivere tutto insieme, condividere tutto».
Clara e André erano la perfetta coppia bohémienne, e inevitabilmente il loro piano fallisce. In dicembre, al rientro dalla spedizione, i funzionari cambogiani scoprono le prove della razzia: i bassorilievi asportati nel “piccolo tempio” di Banteay Srei. André e Louis vengono arrestati e nel luglio del 1924 sono condannati: tre anni di prigione Malraux, diciotto mesi Chevasson. Clara, dopo aver simulato un tentativo di suicidio con il gardenale, un barbiturico, aver trascorso settimane in ospedale ed essere fortunosamente rientrata in Francia, riesce a creare il “caso Malraux”. La sua petizione in favore del compagno è firmata da tutti gli esponenti dell’intelligenza francese. Alla fine, dopo aver venduto libri, gioielli e quadri per sostenere le spese, ottiene il rilascio e il rimpatrio per Malraux e Chevasson, anche se non l’assoluzione.
Il grande sfondo di questa storia è Angkor, «la madre di tutte le città perdute», ma anche «città mai perduta, sempre ritrovata», luogo dove la vita e la storia proseguirono dopo la fine dell’impero khmer, ma che l’occidente pensò di aver fatto emergere dai misteri della giungla quando nel 1860 l’esploratore e naturalista francese Henri Mouhot, durante una delle sue spedizioni verso il Laos, quasi per caso s’imbatté nelle rovine dell’antica capitale khmer.
Inquadrando meglio la scena siamo a una trentina di chilometri da Angkor, lungo quella che era l’antica Via dei Re, un percorso di templi dai monti Dangrek, al confine fra Thailandia e Cambogia. Malraux l’aveva paragonata al “sacro cammino” medievale che univa le Fiandre a Compostela, punteggiato da cattedrali e piccole cappelle. Uno di quei piccoli templi è Banteay Srei, costruito nel X secolo in onore di Shiva e Parvati. Henri Parmentier, architetto, archeologo e storico a capo della missione archeologica dell’École Française d’Extrême-Orient (Efeo) all’inizio del Novecento, lo definisce la «cittadella della bellezza», «una sorta di piccolo gioiello nella giungla». Sembra che sia stata proprio quell’immaginifica descrizione a ispirare André Malraux nella sua avventura.
Luoghi come i siti angkoriani sono labirinti culturali. «Sogni di un luogo», li ha chiamati Arbasino. «Cammino in quei luoghi con parecchie commozioni e inquietudini fra i torrioni con sorriso buddhista franante e lunghi ponti a intrecci di serpenti magici», si legge in un suo articolo. «Angkor materializza il senso della ricerca proustiana, di un amore che cresce quanto meno posseduto, quanto più immaginato», ha scritto la saggista e critica letteraria americana Phyllis Rose, con afflato poetico. In realtà proprio la storia di Malraux dimostra che l’amore può eccitare il desiderio di possesso sino alla razzia. Per denaro, certo, lo ammise. Ma anche per l’incanto di quelle opere. Forse fu per questo stesso desiderio di possesso che Parmentier avrebbe poi cercato di giustificare se non addirittura occultare l’impresa di Malraux.
Per comprendere il fascino di questi luoghi bisognerebbe averli visti nel loro stato naturale. Mi è accaduto, per esempio, nel tempio di Trapean Noem, a Beng Mealea, una quarantina di chilometri da Angkor. Quando fu possibile visitarlo, dopo che da quella zona si erano ritirati gli ultimi khmer rossi, era ancora invaso dalla vegetazione, con cumuli di pietre, colonne e sculture sparsi ovunque. Il tutto non per «illuminata scelta» degli archeologi, com’è accaduto in alcuni templi di Angkor, ma per le caotiche leggi della natura e della storia nonché per le mine di cui era stata disseminata. Fu là, tra statue delle apsara, le danzatrici celesti, mani, piedi e acconciature come arabeschi attorno al corpo nudo, e delle devata, le dee protettrici che levitano su un fiore di loto, che compresi anche la tentazione che possono esercitare.
Tutto questo Malraux l’ha esorcizzato, metabolizzato e scontato nel suo romanzo La via dei re. Qui l’avventura, come disse lui stesso, «sono formiche schiacciate sotto il palmo delle mani, insetti, rettili, insidie ripugnanti a ogni passo che si fa nella giungla». Ma è anche, come si legge in un commento al libro, «l’estremo confronto dell’individuo con la sua ossessione e al tempo stesso con la sua paura della morte: e dietro questa mescolanza narcotica di sensualità e sauvagerie traspare il disegno di un’iniziazione tragica dell’uomo al proprio destino».
«Su questo posto sono state dette infinite coglionerie. C’è troppo spazio per l’immaginazione qui», mi avvertì, vagamente irritato, Claude Jacques, uno dei massimi esperti d’arte khmer, in una tranquilla serata nel giardino dell’Auberge du temples di Siem Reap, la città cambogiana alle porte di Angkor. Il raffinato studioso dell’Ecole Française d’Extrême Orient, scomparso qualche anno fa, non si lasciava confondere dalle suggestioni che gravano su questo patrimonio culturale dell’umanità.
Ma per riuscirci bisognerebbe essere come lui. «Prima devi studiare», era il consiglio di Claudio Bussolino. Arrivato in Cambogia al seguito delle truppe vietnamite che liberarono il paese dai khmer rossi nel 1979, Claudio aveva deciso di rimanerci, per vivere un sogno individuale di rivoluzione etica e culturale. In fondo anche lui era vittima delle suggestioni che gli suscitavano «queste pietre che raccontano di un grande impero e illuminati re». Il suo modello era Jayavarman VII (1181-1220), uno dei massimi creatori di Angkor, illuminato governante, guerriero, filosofo e mistico. A casa sua ne teneva un busto accanto a un ritratto di Lenin.
Sembra proprio che l’immaginazione sia destinata a prendere il sopravvento. Ma è la realtà a essere romanzesca. Accade quello che Pierre Mac Orlan diceva per l’avventura: «È nella fantasia di chi la insegue e, non appena si riesce a toccarla con un dito, svanisce, per fare capolino da tutt’altra parte, sotto una diversa forma, ai limiti dell’immaginazione». E così la storia di Malraux predatore di un tempio perduto ne fa apparire altre. Sono anche le «narrazioni nascoste» scoperte ed evocate da Lia Genovese, studiosa che si è dedicata all’indagine delle romanzesche ricerche archeologiche nell’Indocina francese.
In una conferenza alla Siam Society di Bangkok – una villa nobiliare in teak di metà Ottocento proprio di fronte a Soi Cowboy, ormai storica via a luci rosse – Lia ha raccontato tutto l’affaire Malraux, cui ha dedicato una puntigliosa ricerca d’archivio e ha lasciato intendere che ci sarebbe molto altro da scoprire e rivelare in tempi a venire. Tanto più per quanto riguarda gli intrecci e gli intrighi politici e accademici.
André e Clara, infatti, dopo la prima avventura sono tornati in Indocina non come cacciatori di tesori ma come attivisti politici e hanno fondato L’Indochine enchaînée, un giornale anticolonialista. Un impegno che Clara avrebbe continuato anche dopo essere divenuta, come disse, «la moglie ripudiata». Entrambi erano esponenti di quell’élite intellettuale che nei primi decenni del Novecento faceva riferimento alla Terza Internazionale. Anche se furono sempre considerati dei «compagni di strada».
«È un peccato che Malraux sia conosciuto per aver trafugato delle antichità in un tempio», ha scritto Raoul Marc Jennar, esperto di relazioni internazionali, consulente del governo cambogiano nel periodo successivo alla caduta dei khmer rossi (1989-1999), nel suo Comment Malraux est devenu Malraux.
«Dovrebbe essere conosciuto per il suo forte sostegno ai popoli colonizzati, per la condanna del sistema coloniale, per la lotta alla corruzione coloniale, la denuncia dell’espropriazione delle terre da parte delle grandi compagnie francesi, per la discriminazione legale attuata nei confronti del popolo indocinese. Era un attivista per i diritti umani». A posteriori, Malraux sembra un uomo dalla doppia personalità. Come se fosse il compagno segreto dei due protagonisti de La Via dei Re. Uno, il francese Claude Vannec, spera di trovare rovine di templi non ancora scoperti e di poterne asportare dei bassorilievi da vendere poi a collezionisti europei. L’altro, Perken, spera di trarre un profitto dalla vendita del materiale archeologico per comprare armi e fomentare una guerriglia locale. L’ombra di Perken apparirà spesso nella vita di Malraux: quando organizzò il corpo d’aviazione internazionale durante la guerra civile in Spagna o durante la Resistenza in Francia. La partecipazione fisica alla lotta è per lui un discrimine esistenziale e forse anche per questo nel Dopoguerra non perdonerà a molti esponenti della sinistra di non aver seguito lo stesso percorso, mentre diventa ineluttabile il suo avvicinamento al generale De Gaulle, di cui diventa il cantore. Nel luglio del 1959 il generale lo nomina ministro degli Affari culturali, incarico creato proprio per lui, che conserverà per dieci anni adottando una politica di grandeur e opere sociali.
Malraux è morto nel 1976, un anno dopo che i khmer rossi avevano preso il potere trasformando la Cambogia in una succursale dell’inferno. Per un regime che aveva sacralizzato la decrescita felice e abolito la moneta, la maggior fonte di finanziamento era il traffico illegale di legname, pietre preziose e antichità. Ad approfittarne fu l’inglese Douglas Arthur Joseph Latchford, detto “Dynamite” Doug per il metodo che applicava per recuperare tesori sepolti. Grazie ai suoi contatti con l’Angka, l’Organizzazione di Pol Pot, divenne uno dei maggiori trafficanti d’arte khmer. Arricchì le collezioni di privati e musei (compreso il Metropolitan di New York) in Europa e Nord America. Lui si definiva un «adventurer scholar» e forse per questa sua connotazione alcuni lo hanno paragonato a Malraux. In realtà Latchford incarna il lato oscuro di Malraux. È, come Malraux scrive nel suo capolavoro La condizione umana, il folle, il nostro «incomparabile, prediletto, che ogni individuo è per sé stesso, e che ognuno vezzeggia nel proprio cuore». È uno di quei mostri che dagli anni Settanta, quando il grande nemico era il Vietnam, ignorarono e poi sostennero i khmer rossi.
«Dovremmo ritrovarci in riva al Mekong per parlare di questa storia», mi ha scritto Bussolino poco prima della sua scomparsa. Per lui era un’ossessione.
Latchford è morto a Bangkok, dove si era stabilito, il 2 agosto del 2020. La notizia, era il tempo del Covid, sarebbe passata inosservata non fosse stato per le questioni legali riguardanti la sua collezione personale – si dice che potesse rivaleggiare con quella del Museo nazionale di Phnom Penh – e le cause intentate dal governo cambogiano. Secondo la dottoressa Lia Genovese, che ne segue gli sviluppi per le inevitabili connessioni che da cent’anni si sono intrecciate nei traffici delle “Blood Antiquities”, la collezione Latchford sembrerebbe destinata a sparire per sempre nel mercato nero. Come dimostrano le recenti rivelazioni secondo cui gli oligarchi russi stanno riciclando denaro sporco nel mercato dell’arte. Da Clara e André Malraux ai fratelli Arkady e Boris Rotenberg.