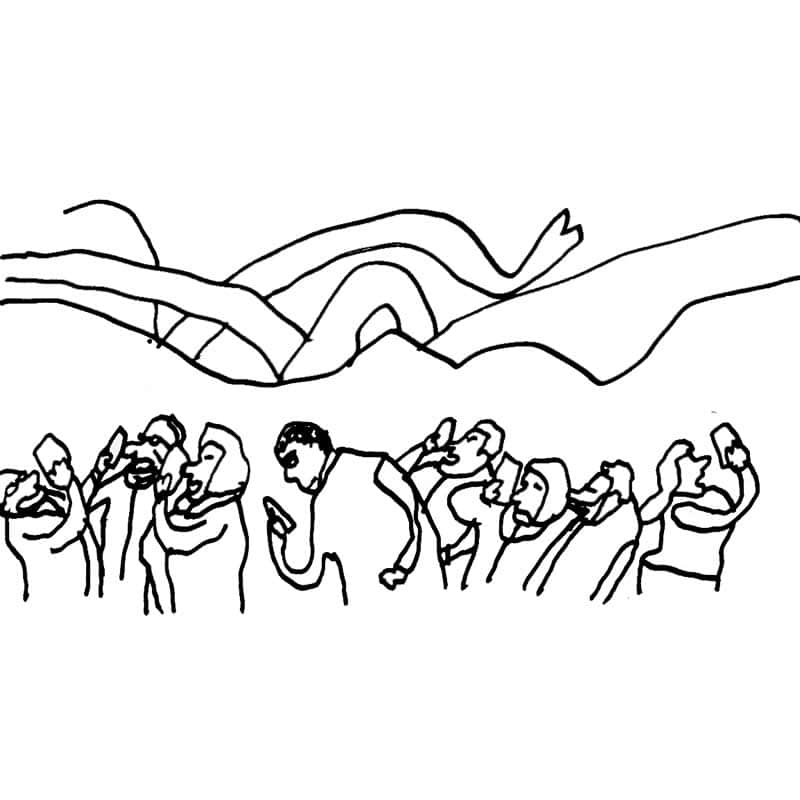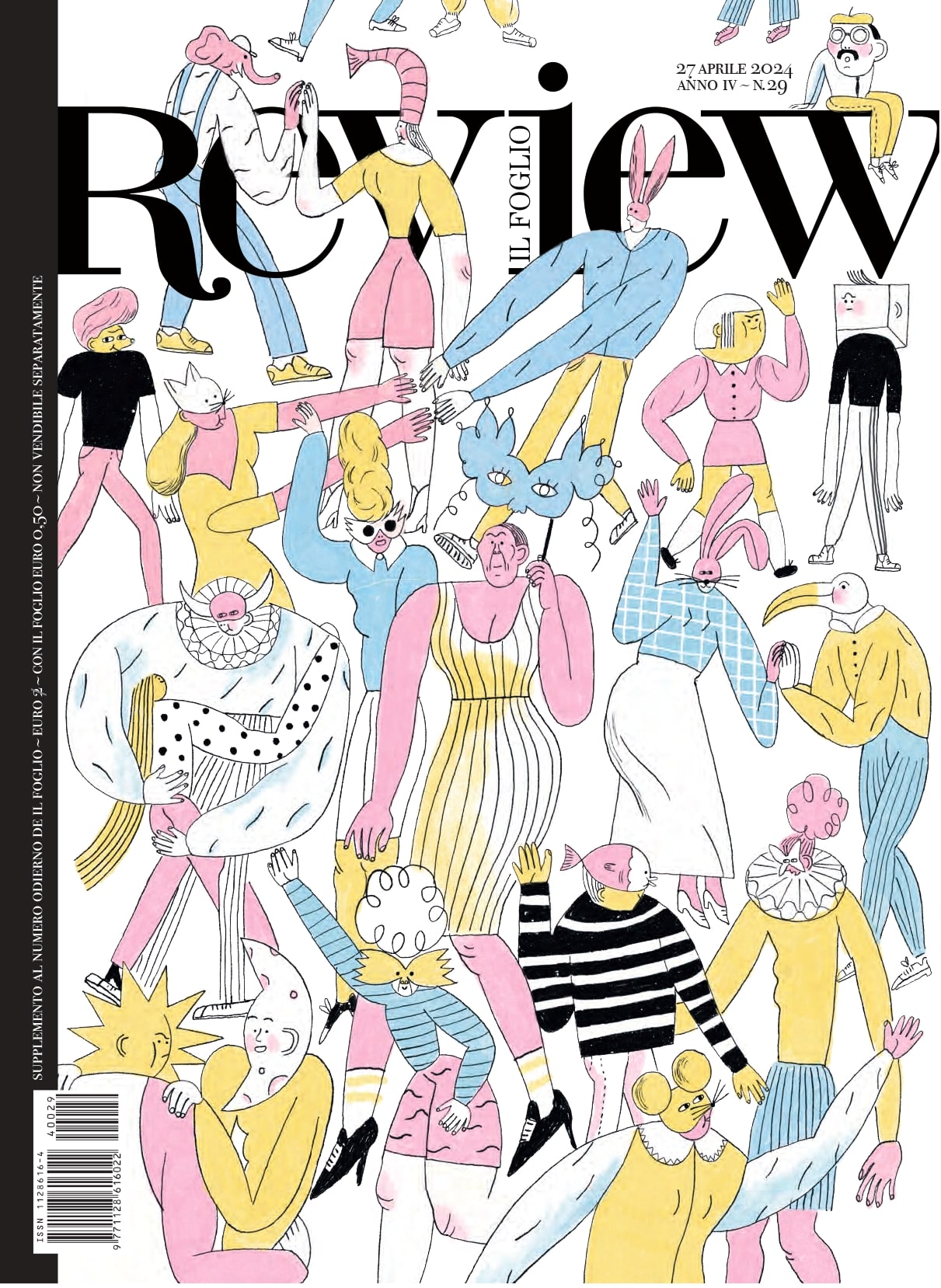Come leggiamo noi che siamo lettrici o lettori di professione? Me lo chiedo quando mi accorgo delle polemiche che a volte possono insorgere rispetto ad alcuni premi, come il Premio Strega, o anche rispetto alle scelte delle case editrici. Posso dire, a mia discolpa quantomeno, che io leggo in modi molto diversi. Leggo per trovare refusi e incongruenze, per studiare i movimenti dei personaggi, per individuare la giusta costruzione delle frasi quando faccio editing a un testo; leggo per valutare se un testo possa essere o meno valido per una pubblicazione per la casa editrice con cui collaboro e devo per forza di caso in caso, per il numero di proposte che devo valutare in poco tempo, attenermi a letture parziali, incomplete, da approfondire; leggo infine per me stessa, per il gusto di leggere.
E per quanto sia difficile spiegare il meccanismo di queste letture, esse procedono automaticamente per modalità differenti.
È come se qualcosa nel mio modo di leggere si adattasse senza saperlo al tipo di lettura che sto per fare. Il mio sguardo su quel testo muta completamente e si sintonizza sulla frequenza del giudizio, dell’intrattenimento, del nutrimento e della scelta, senza che io sappia come questo sintonizzarsi avvenga. Tra queste letture, per quanto possa risultare strano e forse sterile per molti, quella che più mi conforta è la lettura da editing, quella in cui cerco una chiave per leggere un testo e proporre a chi lo ha scritto dei miglioramenti. Questa lettura, che potremmo definire tecnica, per me risulta comoda, piacevole, sono in grado di svolgerla in molti contesti, anche quelli del viaggio, anche quando per esempio non sono al meglio fisicamente o mentalmente. Leggere i testi altrui e analizzarli per sé stessi si trasforma per me facilmente in un rifugio, uno spazio artigianale dove metter le mani in pasta e confrontarsi con le parole. C’è chi sferruzza, chi si incastra nei codici html e chi come me fa editing.
Mi risulta molto più difficile invece valutare la pubblicabilità di un testo, perché le variabili sono moltissime e non sempre un testo che mi piace può essere utile alla casa editrice a cui sto pensando. Possono esserci molti motivi che riguardano la linea editoriale, le difficoltà di investimento, la cautela rispetto alle nuove voci, le pubblicazioni precedenti di un autore o autrice già editato presso altre case editrici. Sarebbe bello, come dice Harold Bloom, poter valutare i testi a prescindere da tutto, a prescindere dalle biografie di chi li scrive, dal contesto in cui vengono scritti, ma a volte per chi pubblica e deve operare delle scelte non è esattamente così. I criteri possono essere molti e anche molto stringenti.
In effetti il tempo che io dedico alle letture libere è assai poco, assai meno di quanto vorrei. Mi ritrovo a dovermelo ritagliare tra numerose altre letture lavorative, letture parziali, letture veloci, letture solo a tratti entusiaste. Per questo sono due i momenti che vorrei annoverare tra i migliori che sento come lettrice: leggere un manoscritto inedito che mi convince e mi trascina e trovare il tempo per leggere un bel libro.
In queste settimane, che sto dedicando molto allo scouting, sono pochi purtroppo i libri “liberi” che ho potuto leggere. E la libertà in questo caso mi interessa su due fronti diversi.
Quello della fruizione, cioè il mio, di chi si trova finalmente a leggere qualcosa a prescindere dai propri obblighi lavorativi per pura curiosità e piacere, e quello delle scritture libere che ho incontrato.
Tra queste sicuramente mi vengono in mente due romanzi diversissimi: da una parte Missitalia di Claudia Durastanti e dall’altra Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini.
Dicevo, due libri diversissimi, infatti lo sono.
Il primo racconta in tre atti figure di donne di realtà e d’invenzione tra passato e futuro di una Lucania senza tempo; il secondo è la narrazione di una donna che è madre e che è una madre terribile, forse anche come persona, come cittadina, ma che comunque nonostante questo viene amata.
Entrambi, però, credo rivendichino questa autonomia, questa libertà pura d’espressione. Da una parte la scrittura galoppante e senza freni di Claudia Durastanti, che fa del suo stile, del tono e della ricerca personali delle armi al servizio di una prosa non scontata e controcorrente; dall’altra il riuscire a narrare la figura di una madre senza sconti, senza vincoli e senza perdoni, cosa assai difficile per chi scrive, cosa che richiede tempo, elaborazione, fatica. Nella lingua, diversa, di entrambi ho riconosciuto del coraggio, della proiezione in avanti, dell’avanguardia, nel senso di un guardare avanti e un non curarsi delle forme prestabilite o delle parole più educate ed educanti.
Ha un grande impatto per chi legge di professione leggere un buon libro, o almeno un libro che una volta letto si reputa buono. Per me si tratta di bagliori, di attimi veloci, di tempi rubati al lavoro, alla produzione, all’editoria, che mi fanno una compagnia efficace, mi danno respiro.
Sarò in grado di valorizzare questa libertà che altri mi insegnano per la mia scrittura? O ancora di più sarò in grado di trovare manoscritti liberi e non conformi da sostenere e proporre al pubblico?
La risposta non è scontata in un mondo di numeri, di vendite, di rese e di occasioni mancate.
Posso dire però che questi spazi di libertà, queste espressioni linguistiche meditate, aprono panorami ampi e ben disegnati, dove la ricerca, la sperimentazione, la stranezza e la forza possono ancora svolgere un ruolo vivido e pieno di significato.
Tanto da regalare a chi legge troppo, a chi legge a volte male, a chi legge senza sosta, degli attimi di tregua.
E la tregua non è mai scontata, è un dono da non sottovalutare.