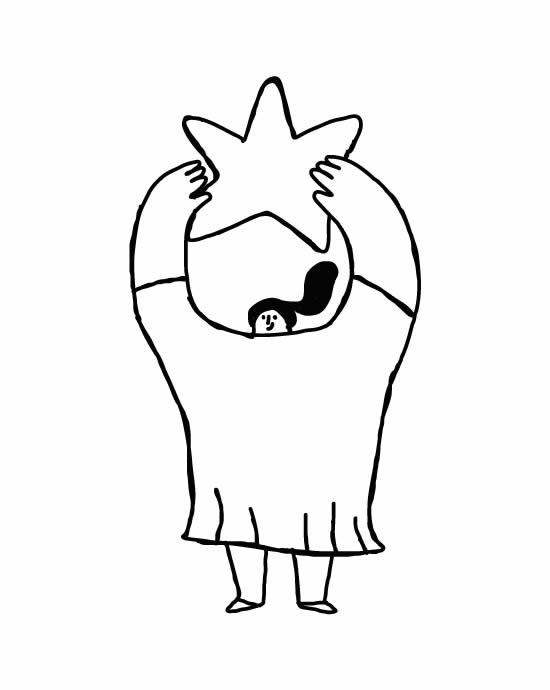Ciao Vero,
sono contento, domani esce il tuo libro. Sono contento e insieme ho dei sentimenti ambivalenti. Sono felice per te: questo libro spero andrà benissimo, sarà amato, e magari ti renderà anche facile la vita. I sentimenti ambivalenti sono quelli che immagini: c’è la strana sensazione di diventare un personaggio di un libro di qualcun altro (qualcuno che ti conosce molto bene), il timore che questa narrazione della nostra famiglia sia così forte da offuscare le possibili altre – anche quelle private o anche quelle che vorrei fare io, e poi una semplice invidia/ammirazione: hai fatto i conti con la nostra faticosa famiglia.
Mi colpisce molto il fatto che questo racconto sia comico, dichiaratamente comico. E mi ricordo che c’era venuto in mente di scrivere un libro insieme, a quattro mani – è stata la genesi di Niente di vero? – sulla nostra famiglia; del resto, ci dicevamo quanti fratelli sono entrambi scrittori?
Ma sono abbastanza contento che l’abbia scritto tu poi questo romanzo comico, anche se chiaramente mi hai rubato metà degli aneddoti famigliari.
Nel tuo libro dici due cose sulla vocazione per la scrittura: ricordi la nostra infanzia come una coalescenza di noia, e parli dello scrivere come una reazione. Io ho davvero la stessa memoria. Il primo racconto che ho scritto lo buttai giù quella volta che restammo intrappolati ad Ascoli Piceno anche con nonna Muccia, ti ricordi? Fu un’esperienza psichica al limite.
Però ti volevo chiedere anche: secondo te da dove viene invece questa vocazione alla scrittura comica? E’ anche questa una reazione? Oppure secondo te nella sgangherata genetica famigliare questa capacità di raccontare comicamente il mondo è passata tra generazioni?
Ciao Chri,
ho l’impressione che l’ambivalenza sia il sentimento di tutte le persone che ti vogliono bene. Non ho mai creduto a chi dice di avere sentimenti puri. E in fondo che dovremmo farcene della purezza? Anche ad avercela, sono sicura che troveremmo il modo per imbastardirla, per renderla ambivalente. Questo libro – a partire dal titolo – si gioca sull’ambivalenza. E un manifesto di ambivalenza. Anzi, un manifesto no, troppo prescrittivo.
Sì, mi ricordo bene quando parlavamo di scrivere quel libro insieme, e mi sembrava un’ottima idea. Poi, forse proprio perché era un’ottima idea, è restata tale, cioè è restata un’idea. Non lo so se capita lo stesso anche a te, ma non sono mai riuscita a scrivere un romanzo pensando: “mi è venuta quest’idea”. O meglio, ogni volta che l’ho pensato, non è successo niente. E’ rimasta l’idea, astratta, funzionante, qualcosa che anche a distanza di tempo poteva continuare a sembrarmi una bella idea. Comunque non sarebbe mai diventata un romanzo.
Non so da dove nascano i romanzi, temo che a voler trovare una risposta andrei a finire in un territorio a metà tra Osho e i Baci Perugina, quindi mi accontento di non saperlo, ma quello che so per certo è che non nascono da un’idea. Almeno per me è così. Mi spiace quindi se ti ho rubato metà degli aneddoti, e vorrei che li considerassi tali: non sono prestiti, sono proprio furti. Se vuoi riappropriartene, devi rubarli anche tu.
Il nostro Natale bloccati nella casetta di Ascoli con la neve fuori è stata un’esperienza psichica devastante per noi ragazzini, eppure oggi, che non sono più ragazzina, mi chiedo questa cosa: forse è stata un’esperienza psichica al limite anche per nostra nonna. O per mamma e papà. Certo, forse in un’altra famiglia nessuno l’avrebbe presa così, per un motivo molto banale: si trattava solo di una nevicata. Saremmo potuti uscire. Fare i pupazzi di neve. Tirarci le palle. Invece ci siamo deliberatamente murati là dentro, con la neve fuori che era arrivata a bloccare la porta. Ho sempre vissuto e pensato all’adolescenza dal punto di vista dei ragazzi, ho sempre sposato e condiviso il loro disagio, lo sentivo mio, era mio, però ultimamente sto cambiando prospettiva. Mi domando: ma come doveva essere per i nostri genitori avere a che fare con noi? Il loro disagio sta cominciando a sembrarmi più comprensibile, più umano. Probabilmente sto invecchiando. Quindi ripensando a quel Natale ad Ascoli, mi immagino la rottura di palle che deve essere stata per i nostri genitori, che non vedo più come i nostri genitori, ma come un uomo e una donna, due persone poco più grandi di me oggi, chiusi dentro casa con due adolescenti molesti e respingenti nel loro malessere, e una madre, o una suocera, a seconda dei punti di vista. Non eravamo solo noi due a soccombere. Quasi mi dispiace di avergli rovinato il Natale. Magari senza di noi essere chiusi in una casa con la neve fuori sarebbe stato più romantico, avrebbe finito per assomigliare a quella famosa copertina del New Yorker con la coppia che guarda fuori dalla finestra.
La vocazione alla scrittura comica, mi chiedi. L’incipit del romanzo – scusa Chri – è “mio fratello muore tante volte al mese”. Ovviamente è un’affermazione assurda, paradossale, però sappiamo che è anche vera. Se abbiamo passato l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta a relazionarci con nostra madre convinta che tu fossi morto perché non sapeva dove ti trovassi in quel momento, la prima reazione non è riderci su, la prima reazione è abbracciare la sua angoscia che diventa la nostra angoscia, anzi la mia angoscia, perché tu in quel momento sei morto, e vivere il lutto, il dolore estremo, la fine di tutto. Vivere ogni volta questa cosa enorme che è la perdita di un fratello. E poi che succede? Succede che il fratello è vivo. Il fratello stava giocando a calcetto. Il fratello si stava facendo la doccia. Il fratello stava vedendo uno spettacolo di teatro civile. La vedi la comicità intrinseca e disperata di questa cosa? Immagina la parabola del figliol prodigo se quel fratello sparisse per farsi i fatti suoi e però tornasse ogni volta. Vitelli grassi sgozzati a buffo. Dopo un po’, l’unico modo di raccontare quella storia sarebbe attraverso un registro comico, ma all’interno di quel racconto ci sarebbe comunque la necessità di chi accoglie il ritorno del figliol prodigo come fosse una festa. La necessità di qualcuno che ci crede. Quindi il padre dovrebbe comunque far fuori il vitello grasso, così come nostra madre festeggia ancora il fatto che tu non sia effettivamente morto. Per farlo però deve credere che la tua morte sia reale. E infatti ci crede. Chi è a quel punto che può raccontare questa storia per renderla diversa? Forse il figliolo non-prodigo, o il vitello grasso, se vogliamo dargli un tocco weird. E mi viene il sospetto che potrebbe adottare un registro comico.
Vero,
non so, sicuramente abbiamo avuto amore dai nostri genitori, e abbiamo subìto le loro angosce, in modo diverso. E’ chiaro a tutti e due, mi sembra, che senza l’altro non ci saremmo salvati. Nessuno poteva testimoniare per così tanto tempo cosa avveniva senza un complice, la collusione sarebbe stata troppa. E quindi, se è vero che anch’io mi ritrovo a mettermi dalla parte di due adulti che ci dovevano sopportare, penso anche che loro avevano una scelta e noi no: lasciarci liberi. Quest’amore per un’ideologia di coercizione nel tuo libro sembra uno sfondo, ma è per me un’interpretazione chiave di un’intera generazione: un double bind perfetto, una libertà dichiarata al massimo grado, una libertà di fatto proibita oltre l’immaginabile. Eppure nostra madre aveva studiato con Bollea, eppure ci parlavano quando avevamo cinque anni di familismo amorale, eppure conoscevamo – te lo ricordi bene – fin dall’infanzia “la differenza tra libertà e libertinaggio”, no? E allora com’è che ci veniva continuamente detto: quanto è bello correre, e allo stesso tempo si era pronti con una scianghetta? Quella che tu chiami ambivalenza per me è un bipolarismo che può essere convertito in letteratura: tragedia e comicità. “Mio fratello muore tante volte al mese” fa ridere se poi appunto sono vivo. Ma portalo all’estremo. Una persona cade su una buccia di banana, fa ridere, si rialza e cade di nuovo, fa ridere ancora. Si rialza ancora e ricade, fa ridere ancora o comincia a essere angosciante? C’è un aneddoto che non mi hai rubato, non mi ricordo se te l’ho raccontato, in cui mia madre mi chiama – avrò avuto 35 anni – alle due di notte, come sai che può accadere, e mi dice che è preoccupata, perché pensa che sono morto: io ero a fare una presentazione fuori Roma, e le urlo: “Stavo a Colleferro, ho conosciuto una e ora stiamo scopando in macchina”, tu sola la immagini la risposta. Te la lascio in bianco.
Ti introduco invece un altro tema. I libri. Ci siamo voluti bene tramite i libri, e ancora in qualche modo ci vogliamo bene tramite i libri. Molte relazioni che tu racconti nel romanzo hanno i libri al centro, proprio lo scambio di volumi. Questi oggetti hanno avuto un potere magico, e anche oggi con questo tuo Niente di vero sembri voler compiere un atto psicomagico. Ma il dubbio che mi viene e che credo ti venga anche a te è che forse invece non funzionano più, era un’illusione crederci, era un trucco. Oppure ti sei ormai arresa che è una truffa, e tanto vale guadagnarci un po’, di soldi, di lettori, di risate, di sollievo?
Chri,
è interessante questa cosa che dici del doppio legame, e non avevo mai pensato potesse essere generazionale, cioè che ci riguarda in quanto generazione figlia di una generazione che provava a sperimentare – a esercitare – la libertà per cui aveva lottato. E che probabilmente ha fallito. Mi fa sorridere, però, alla luce di questo, che mi dici di essere ossessiva e maniacale perché mi aspetto che le persone facciano quello che dicono, insomma che la fai passare come una mia fisima, una stramberia, il fatto che vado fuori di testa se qualcuno vive con naturalezza questo sfasamento. Dici che è una reazione?
Mi dispiace per la ragazza di Colleferro, mi chiedo anche se la mia solidarietà femminile – essendo vissuta con modelli femminili terrificanti – l’abbia sviluppata proprio a partire da questo, immedesimandomi con le ragazze che frequentavi e che avevano a che fare con nostra madre. Magari ho sviluppato un’inconsapevole sorellanza, chissà. Era come se mi venisse comunque più naturale mettermi dalla parte di chi non era famiglia, anche se si trattava di una sconosciuta. Un amico mi ha chiesto perché abbia dedicato il libro a tre mie amiche e a nessuno della mia famiglia, e se considerassi le amicizie la famiglia che si sceglie di avere. Forse oggi la vedo davvero così, e ci ho messo del tempo per capirlo. Ripenso a quando avevo dedicato il mio secondo romanzo a papà e al nonno. Anche quel libro parlava della nostra storia famigliare, quella paterna, ma in maniera del tutto trasfigurata, non aveva niente dell’autofiction o del memoir, era un romanzo vero e proprio. Nostra zia, la sorella di papà, l’aveva letto e mi aveva detto: “Tuo padre non c’è più, ma non sarebbe stato orgoglioso di te”. Non so se lei se lo ricorda, ma io ovviamente me lo ricordo molto bene. E la violenza di quella frase, la violenza della famiglia, è qualcosa che non ho mai trovato così nei rapporti di amicizia. Anche lì c’era di mezzo un doppio legame, perché poi zia mi ha abbracciato, come a dire: sono tua zia, ti dico queste cose perché ti voglio bene.
Forse per questo preferivo volerci bene attraverso i libri. Sia con te, sia con le persone che ho scelto. Sì, scambiarsi i libri è stato un rito, uno di quei riti di iniziazione da confraternite americane, quindi in un certo senso significava credere alla trascendenza di quello scambio, di quel gesto. Non cercavo la trascendenza nei libri in sé, nella lettura, ma avevo bisogno di questa mediazione. Potrei dire che le cose non sono veramente cambiate da quando ero una ragazzina. Per me la trascendenza non sta nella letteratura, nella letteratura in sé, quella con la L maiuscola, chiamala come ti pare, ma in chi mi accompagna nella scoperta di qualcosa, nel rapporto, nelle persone. Non mi piace amare le cose da sola, anzi mi fa stare malissimo.
Senti Vero,
però spieghiamola meglio questa cosa che io dico di te. Io dico che tu hai una nevrosi, molto novencentesca sì, forse un antidoto al double bind, per cui dai di matto se le parole che una persona pronuncia non coincidono perfettamente con i comportamenti o con degli impegni. Ti richiamo domani, se poi non accade, per te diventa un problema. Ti ho chiamato quattro volte, se invece sono state due, questo diventa un affronto. Quale sia la genesi di questa nevrosi non lo so. Io a questa manipolazione linguistica ho reagito consapevolmente con un’ideologia della dialettica: spiegare sempre, rivedere, chiedere scusa. Sai quanto io sia un fanatico del chiarire.
Rispetto invece all’episodio di Colleferro, come vedi, io sono in una posizione ancora più paradossale della tua che ricevi allarmi di nostra madre sulla mia morte ripetuta. A Colleferro io ero andato a fare una presentazione, non avevo conosciuto nessuna persona e non stavo scopando in macchina. Ma come sai, i dati fattuali poco interessano a nostra madre. Se per te è complicato avere a che fare con un allarme rispetto a tuo fratello morto sempre che poi invece è vivo, dico proprio dal punto di pragmatica linguistica, sai anche cosa vuol dire se il sopravvissuto a una nontragedia sei tu. Quello che forse ha fatto sviluppare a te un senso di sorellanza, a me sul lungo periodo ha fatto sviluppare una sorta di sana misoginia. Non ne posso più di donne che prendono così sul serio il proprio dolore tanto da renderlo intraducibile, quell’immagine di Monica Vitti che dice mi fanno male i capelli, che vuol dire? Dove ti fa male: la cute? Allora forse c’è un’irritazione e va trattata con una pomata. Se è cefalea, allora forse c’è un problema di postura. Chiaramente questo non facilita le relazioni né la comunicazione. Non riesco a capire troppo quelle persone che vogliono essere solo ascoltate quando hanno un dolore o un problema, e non vogliono invece capire come alleviare un dolore o risolvere un problema. Ma tant’è, forse ho deciso di fare politica e meno poesia per questo.
Rispetto a tutto quello che dici invece nello scambio precedente, ti riporto al tuo libro, che non ha nulla, volutamente credo, di generazionale. La protagonista, la Vero del libro, è solitaria, idiosincratica; eppure tu e la stessa Vero del libro cercate e avete una forma di socialità e un amore per l’amicizia, per lo stare insieme, che è una delle cose più dolci del romanzo. Quando dici che “amare le cose da sola” ti fa stare malissimo insomma, a cosa ti riferisci?
Chri,
mi fa un po’ impressione che il giorno in cui ricevo questa tua mail è morta Monica Vitti, e i social si dividono tra commenti a Sanremo e il mi fanno male i capelli. Mi fa anche impressione che un verso di Amelia Rosselli sia diventato iconico tramite Vitti e che, decontestualizzato, possa sembrare persino una battuta, una frase comica. Di fatti: era una metafora della depressione o un modo per sdrammatizzarla? So di essere stata – e lo sono ancora – una a cui fanno male i capelli. Mi verrebbe da dire: “quel tipo di donna”, ma è un’espressione che odio, la trovo fastidiosamente ammiccante e, da traduttrice, mi sembra un calco dall’inglese. Però so anche di trovare insopportabile la versione di me per cui il mi fanno male i capelli può essere una rivendicazione. Ora non ci addentreremo in questo dibattito, tu hai molta più fiducia di me nella politica, anche per quanto riguarda il disagio psichico, e non vorrei farne nemmeno una questione di genere. Tuttavia, ripenso a nostro padre per il quale il dolore ai capelli probabilmente non significava un bel niente; lui era un uomo che poteva – che pretendeva – di relazionarsi ai problemi solo in una maniera pratica, eppure è stato anni e anni vicino a una donna depressa come nostra madre. Che sarebbe cambiato se avesse ipotizzato un dolore ai capelli? E mamma come avrebbe potuto esprimere quel dolore? Non è mai stata una persona poetica. Qui potrei dire: “non quel tipo di donna”, se non odiassi dirlo.
Rispetto alla tua domanda, la mia socialità è stata una scoperta molto recente. Ho sempre avuto un’idea di me come di una bambina, di una ragazza, e poi di una donna solitaria, e invece mi rendo conto di essere dipendente dalle amicizie, dalla condivisione. Non so perché non l’abbia mai vista in questi termini, cos’è che volessi preservare in quell’immagine di solitudine. Forse davvero è un’immagine che mi viene dai libri: è molto più facile innamorarsi di personaggi che sembrano al riparo dal mondo, immersi nelle loro tragedie, nei loro amori, nei loro fallimenti, personaggi idiosincratici e inetti alla vita sociale. E se ci penso, non ho mai amato molto libri che parlano dichiaratamente di amicizia. Mi trovi un po’ spiazzata, perché mi sembra di vivere ancora dentro questa contraddizione, di non riuscire a trovare una risposta alla tua domanda se non a costo di un tradimento.
Vero,
sì, oggi è il giorno in cui tutti e soprattutto tutte omaggiano Monica Vitti e la seconda serata di Sanremo. E quindi è il momento giusto per finire questa conversazione con un po’ di iconoclastia. Vitti: l’attrice di Antonioni e l’unica attrice comica italiana a cui è stato permesso di stare in quel brat pack che sono i grandi maschi della commedia all’italiana: Sordi, Manfredi, Gassman, Tognazzi, Totò, Mastroianni. Eppure riguardiamole le sue performance: che idea di donna ha incarnato, sempre l’idea di una donna costruita sul desiderio di altro, sull’assenza, sulla mancanza, sulla sprovvedutezza. E qui provo a incalzarti su un aspetto chiave del tuo libro: il protagonismo femminile. Dopo aver scritto un libro su una coppia di omosessuali, un altro su una donna borghese fedifraga, uno su uno stupratore inconsapevole, adesso c’è questo alter-ego post-isterico al centro di un tuo romanzo. Nel frattempo “le donne”, come mi ha detto qualche giorno fa una mia amica regista che stava facendo una domanda per dei finanziamenti, “vanno di moda”: riscopriamo Annie Ernaux e Joan Didion, Clarice Lispector e Natalia Ginzburg. Era quello che cercavi? Era quello che cercavamo, mi viene da chiederti, nella complicità che avevamo con i libri. Mi ricordo quanto è stato importante per noi leggere Franny e Zooey, una storia di fratelli, e avere come idolo morale Seymour Glass, il protagonista delle saghe salingeriane, ma c’era un passaggio mi ricordo, in cui si diceva di un bambino a cui non importava distinguere maschi e femmine, che è una cosa diversa dalla fluidità o dalla ambiguità dei generi: è piuttosto una sorta di trascendenza, di indifferenza. Davvero ci interessa così tanto questa roba dei maschi e delle femmine? A me in qualche modo piacerebbe tornare a uno stato di incanto assoluto che è quello che può dare la letteratura, poter far convivere vivi e morti, svegli e dormienti, quel momento in cui ci addormentavamo a casa dei nonni e nonno ci raccontava delle storie assurde. Provavamo a interagire nel dormiveglia e sembravamo parlare nel sonno. Come era quella storia di: Vi dirò tutto, vi dirò tutto, tranne il prezzo?
Eh, Chri,
me lo ricordo bene quanto è stato importante per noi Franny e Zooey, e poi ovviamente anche il mio tentativo di leggere i Racconti del pellegrino russo sforzandomi di farmelo piacere. Mi viene da pensare questa cosa, sentendomi sempre orfana di maestri e di maestre: nella letteratura cercavo i fratelli e le sorelle, non le madri e i padri, in un certo senso cercavo la possibilità di una famiglia senza il problema della discendenza, dell’eredità. Non so se è una versione del post-moderno, un ripensare la Storia senza giornate della memoria, un universo dove la memoria è comunque presente. Se ci pensi, il nonno – che infatti per me è stato una specie di fratellone Seymour – ci raccontava della Guerra in questi termini, non per conservare la memoria di ciò che era accaduto, ma per averla lì, senza soluzione di continuità; eravamo immersi nei suoi racconti: i suoi commilitoni, la signora che gli dava il pane di nascosto, erano presenze vive, come lo erano gli animaletti delle favole che si inventava – astruse, strampalatissime, senza capo né coda. Era la nostra serialità televisiva, ma una serialità priva di tiranti e colpi di scena, ignara dell’evoluzione del personaggio. L’aneddoto di cui parli lo ricordo male anche io, c’era il nonno che raccontava una sua favola e noi, come sempre, intervenivamo per fare domande o aggiustamenti sulla trama, e poi – quando io dovevo essere già sprofondata nel sonno – me ne esco fuori con quella frase fuori contesto, detta da chissà chi, da qualche creatura onirica che avrebbe rivelato tutto tutto, tranne il prezzo! E voi due ovviamente siete scoppiati a ridere. La verità è che abbiamo sempre amato molto di più il nonsense che lo storytelling.
v.
Ps.
A proposito, mamma mi ha detto che chiede a te se può leggere il libro, mi raccomando vai di nonsense per tergiversare!