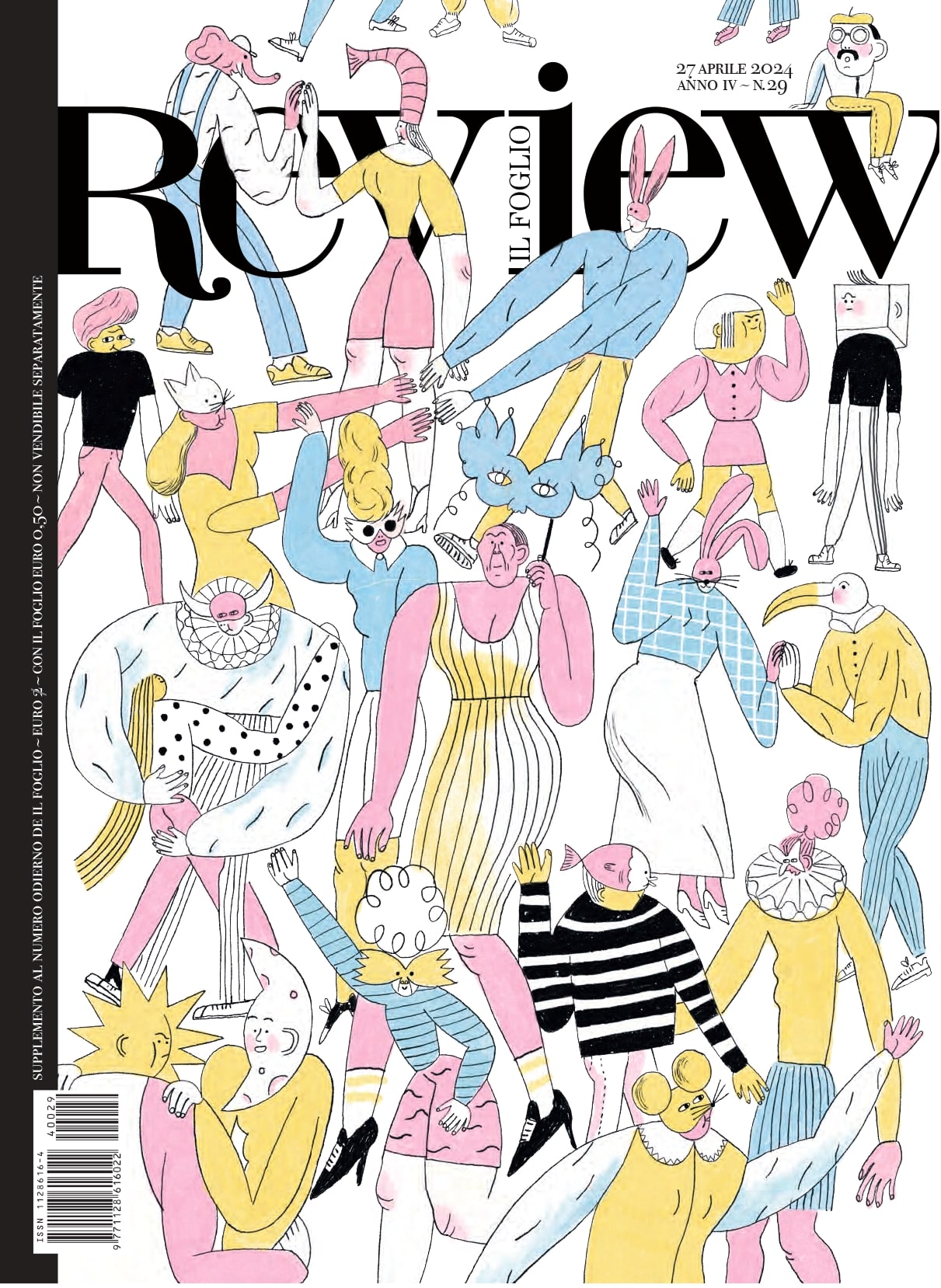È da quando sono nata che vorrei non essere nata in Italia; ho costruito un bilinguismo intuitivo e infantile molto prima di avere i mezzi e la possibilità di scappare; poi però, quando ne ho avuto la possibilità sono sempre tornata. Lo sforzo della vita da immigrata non l’ho voluto fare, avrei voluto che altri l’avessero fatto per me prima di me, come regalo. Leggendo L’Idiota, di Elif Batuman, pubblicato in America nel 2017 e in Italia da Einaudi nel 2018, ho trovato questa gratitudine in Selin, nata negli Stati Uniti da genitori turchi, che studia a Harvard, un personaggio che diventa grande attraverso un amore più immaginato che vissuto. È una storia di formazione che non ha niente dei luoghi comuni dei libri sull’immigrato di seconda generazione (incertezza sul proprio posto nel mondo; sentirsi sradicato; l’accettazione degli altri; il buon cibo della nonna). Selin lo spazio lo occupa, sa che si merita tutto, e vuole tutto: si iscrive a cinque corsi per semestre, invece di quattro, contesta i professori, si innamora di Ivan e lo insegue in Ungheria. L’America la abita pienamente, dai banchi del suo corso di Letteratura a Harvard.
In Aut Aut, che è il seguito de L’idiota, ritroviamo Selin, che è l’alter ego autobiografico di Batuman, al secondo anno di università, dove detesta che le dicano che non c’è fretta, e detesta che nessuno si adoperi come lei a risolvere il mistero della vita, o quantomeno a trovare modi meno noiosi di abitarla. Quella di Selin non è una gratitudine compensativa, in quanto figlia di genitori che hanno fatto sacrifici, è, al contrario, consapevolezza delle opportunità, voglia di vita da aprire e capire, da vivere al meglio, anche se «in questo fancy brand name sinonimo di eccellenza che è Harvard, Selin era convinta che le persone avrebbero avuto qualche idea alternativa su come vivere, un modello diverso rispetto a fare soldi e pagare per le cose, fare figli e fare abbastanza soldi per mantenerli». Batuman lo racconta durante la nostra conversazione a Roma, e lo scrive anche nella sua pubblicazione su Substack, Elif Life, un progetto molto interessante di scrittura personale, dove l’autrice torna sui temi e continuamente li rivisita con nuove letture. Perché le sue, anche nella narrativa, non sono realizzazioni che accadono una volta per tutte, ma un pensiero continuo che costruisce sugli assunti precedenti e così dà forma a una ricerca personale.
In Aut Aut, Selin dice: «Mi dava fastidio quando la gente si comportava come se niente di quello che facevamo avesse un carattere d’urgenza. “Avete tanto di quel tempo, non c’è bisogno di farsi prendere dalla fretta”. Era quello che ti dicevano i presidi quando tu cercavi di infilare cinque corsi nel piano di studi. Facile per loro: erano già presidi. Quindi, o quello era il lavoro che avevano sempre desiderato, e in quel caso potevano permettersi di tirare un po’ il fiato, oppure non avevano mai desiderato farlo e adesso il loro scopo era impedire a chiunque altro di realizzarsi nella vita». Mentre la madre è felice che in America i bambini possono fare i bambini, Selin prova, di fronte alle imprese dei bambini-prodigio, «uno struggente desiderio e un profondo senso di fallimento». È questo desiderio di realizzazione, alla base, l’arco narrativo sia dell’Idiota sia di Aut Aut. La sfida di Selin di diventare sé stessa, attraverso o più spesso nonostante la grande ossessione amorosa del primo volume e le energie creative sperperate nello struggimento e nella ricerca di altra “vita amorosa”, nel secondo. Eppure L’Idiota, che in quanto libro che parla di ragazze è un libro profondamente politico, è stato letto a volte come libro disimpegnato. Una lettura che Batuman ha accettato senza replicare per un certo numero di volte – un uomo nel pubblico a Berkeley le chiede di leggere un passaggio del suo stesso libro per spiegarle che il suo personaggio e di fatto lei non erano sensibili alla cronaca del 1995 e 1996; e un relatore a Mantova, che usa esattamente lo stesso passaggio per lo stesso argomento. Ma dopo Mantova Batuman ha una realizzazione e comincia a capire che «non c’è niente di più politico della questione di come alcune fasce di popolazione sono allontanate dalla politica». In un articolo sulla London Review of Books scrive: «Da bambina mi sentivo oppressa dal notiziario, dal modo in cui l’umore nella stanza cambiava quando in televisione comparivano gli uomini, per parlare dei grandi fatti importanti di altri uomini, e dall’aura di gravitas che circondava questi fatti, che sembravano annullare e delegittimare qualsiasi altro aspetto della vita, tutta la sfera domestica, tutte le cose che i bambini e le donne prendevano sul serio».
Durante il nostro incontro a Roma le dico che si può sempre contare su un relatore misogino italiano per raggiungere delle realizzazioni importanti, e che a me fanno raggiungere turning points praticamente tutti i giorni. Ci troviamo d’accordo sul fatto che a Berkeley come a Mantova, anche in un ambiente perlopiù illuminato, capita ancora di incontrare questa lettura essenzialmente machista della politica, e cioè una lettura della sfera pubblica come una questione tutta di princìpi che non contiene nulla di emotivo-privato, una lettura che stride con l’esperienza vissuta: nessuno va a combattere una guerra per princìpi teorici, ci sono sempre le emozioni, le vite intime. Oggi è cambiato il perimetro di quello che i giovani considerano politica. Le chiedo quando ha inquadrato il suo libro L’Idiota come libro profondamente politico, «un testamento della vasta gerarchia intersezionale che conduce allo sfruttamento ambientale, razziale e sessuale» che tratta anche il tema, centrale, della depoliticizzazione delle vite delle donne e dei bambini.
«È stato un processo. Ho scritto la prima bozza dell’Idiota verso i vent’anni, era un mondo completamente diverso, un mondo pre 11 settembre. Poi l’ho ripreso ed editato alla fine dei miei trent’anni, ed è uscito l’anno che ne ho compiuti quaranta. Era anche il mio primo anno di relazione con una donna, dopo una vita in cui avevo frequentato solo uomini. Ed era l’anno del MeToo e il primo anno della presidenza di Trump, e subito dopo, quando facevo ancora presentazioni, nel 2018, è stato l’anno dell’udienza di Christine Blasey Ford contro Brett Kavanaugh (giudice della Corte suprema – Ford, sua compagna di studi a Harvard e oggi psicologa dell’infanzia, aveva testimoniato contro Kavanaugh accusandolo di violenza sessuale). E questo mi ha fatto ripensare al passaggio dell’Idiota in cui Selin parla dei gov jocks, questi tipi che vanno a Harvard e sono praticamente addestrati dalla nascita per la politica, sono destinati alla politica, e Selin si chiede “ma questi saranno i nostri governanti?”. E Brett Kavanaugh è esattamente uno di questi gov jocks. Ho ripensato a tutta una serie di scelte e di circostanze che avevano allontanato me dalla politica, che mi avevano condotto a studiare letteratura, e avevano allontanato Christine Blasey Ford dalla politica. Perché? Ho avuto questo pensiero ininterrottamente per tutto quell’anno». Una cosa che ripete spesso Elif Batuman è la necessità di ripensare anche la linearità del racconto, anche nell’essay, quindi sottolinea che non ha mai una realizzazione puntuale ma ama il processo di “scrittura cumulativa”, che io definirei ricorsiva, in cui può fare riferimento a cose scritte e scoperte in precedenza. Durante il dottorato a Stanford in Letteratura russa (e dopo aver scritto e accantonato la prima bozza de L’Idiota), ha scritto il suo primo articolo per il New Yorker, dove è stata assunta nel 2010 come staff writer e dove tuttora lavora. «Per molti anni non ho scritto proprio nessun libro, in parte perché mi stavo concentrando sul giornalismo, con cui avevo capito che potevo mantenermi, e in parte perché così tante delle mie energie e del mio tempo andavano nelle relazioni “romantiche”, un fenomeno che ha descritto bene Shulamith Firestone, nella Dialettica dei sessi, anche se io ai tempi non lo sapevo». Una pagina della Dialettica dei sessi Batuman l’ha adottata come manifesto del suo sito, una parte in cui si dice che da donne sprechiamo (ma siamo quasi obbligate a farlo) i nostri migliori anni creativi nella ricerca e nel mantenimento dell’amore romantico, perché per noi l’amore romantico-erotico rappresenta una questione di sopravvivenza nella società patriarcale; mentre al contrario, agli uomini viene insegnato che l’amore è qualcosa da cui devono scappare, qualcosa che li incastra. E questo conflitto, di “voglio e non mi vuoi dare amore” (che a parti inverse vale per il sesso), ci logora, ed è di questo che parliamo nelle nostre conversazioni da ragazze, conversazioni-fiume in cui ci passiamo la saggezza di sopravvivere in questo sistema in cui l’amore di un uomo è vitale per validare la nostra stessa esistenza. Da Firestone: «Non sorprende che le donne arrivino così esauste all’inizio di qualsiasi sforzo [di carriera, di realizzazione] significativo. Ci vuole tutta la maggior parte dell’energia di una donna nei suoi migliori anni creativi per “trovare un partito”, e il resto della vita per tenerselo. Ma questa caccia all’uomo è caratterizzata da un’urgenza emotiva che va ben al di là del desiderio di un impegno reciproco».
Alla mia domanda su come si supera questa dinamica, Elif valuta che forse questa cosa a un certo punto passa per l’età, o perché lei è uscita dal contesto di relazioni con gli uomini, «che richiedevano energia e motivazione perché c’è sempre questa guerra di impegno contro libertà. È un prodotto della socializzazione: se sei una ragazza sei una sfigata se non hai un ragazzo, se sei un ragazzo sei uno sfigato se ti sei fatto incastrare da una ragazza. Una cosa tossica». Entrando nella relazione con l’attuale compagna, l’amore non era più un bene da trattenere, non si doveva temere di darne troppo e quindi spaventare l’altra persona, e cita Adrienne Rich, Compulsory heterosexuality and lesbian existence fra le varie letture di femministe della seconda ondata che l’hanno aiutata anche nel processo di presa di coscienza post pubblicazione dell’Idiota.
«Per tanti anni ho strutturato la mia vita attorno ai problemi dell’amore e dell’innamoramento, del resto anche la letteratura o parla di amore o di guerra, e la guerra non mi interessa. Ma come superarlo [il problema di farsi prosciugare dal lavoro dell’amore] è un tema aperto, sto provando a scriverne proprio ora. Mi ha colpito un’introduzione all’Inferno di Dante, che cita l’episodio di Paolo e Francesca come una rivisitazione del Dante ragazzo da parte del Dante adulto. Che è come dire che per scrivere di amore romantico devi aver raggiunto una certa distanza e anche un livello di sviluppo personale che va oltre quel tipo di ossessione. Insomma l’amore è da una parte una forza che ti fa trascendere l’ego ma ti può anche rinchiudere nell’ego, o nella piccolezza». Mi racconta anche del corso di scrittura che tiene al Barnard, un college di sole donne, e di come, nonostante possa selezionare le scrittrici con cui sente più sintonia, ogni tanto si trova impaziente rispetto a questa centralità dell’ossessione amorosa negli scritti delle sue studentesse. «A volte scrivono questi brani, magari incentrati su una dinamica con un fuckboy, che per carità capisco, ne ho scritto io stessa [ne L’Idiota], ma quelle sono le volte in cui mi sento alienata dalla loro scrittura. Perché il problema è che cercano di far sembrare questo personaggio così misterioso, e “chissà a che cosa sta pensando, con quelle sue unghie smaltate di nero e la custodia della chitarra in spalla…” e io penso: “Te lo posso dire io a cosa sta pensando, sta pensando a cosa mangiare per cena. Non sta pensando a quello a cui pensi tu”. Ma non so come dirglielo. E allora faccio leggere Shulamith Firestone». La vicenda editoriale di Batuman è che, già durante il dottorato, scriveva cose che lei pensava come narrativa ma venivano pubblicate come essay, e si è ritrovata con una “carriera come scrittrice di essay”. Senza riprendere L’Idiota, per un paio di anni si è rimpallata con la sua prima agente una serie di idee «di libri che non avrei voluto neanche leggere, figuriamoci scrivere». Fino a che qualcuno, l’editore del suo primo libro, I posseduti, le ha detto «sono stanco di vedervi bisticciare. Tu un libro ce l’hai già. Prendiamo tutti questi essay, aggiungiamo delle parti, e il libro c’è». Le dico che queste sono le persone di cui abbiamo bisogno, pratiche e portate a finalizzare, e lei è talmente d’accordo che mi dice che infatti quel libro, un memoir sulla letteratura russa raccontato da una studentessa di dottorato, l’ha venduto felicemente per settemila dollari (un anticipo molto basso per il mercato statunitense). «Inizialmente per me anche quel libro era un romanzo. Poi mi è stato detto che commercialmente era meglio vestirlo come non fiction, che le persone volevano avere l’impressione di imparare qualcosa. Ma queste sono categorie editoriali, ai lettori non interessa, i lettori si riferiscono a quel libro come a un romanzo. Ed è andato meglio del previsto e ho avuto un riscontro». Ha scritto che un tempo era molto arrabbiata e ora non lo è più, le chiedo se mi dice come ha fatto a cambiare, perché io sono sempre furiosa, e lei mi dà l’unica risposta vera, quella che di solito chi ce l’ha fatta non ti dà: il successo ti toglie la rabbia. «E più che rabbia era proprio l’oltraggio di sentirsi completamente inascoltata, di essere senza voce. Ora ho una piattaforma molto più ampia, un rinforzo positivo». Dice anche che tendeva di più alla depressione che alla rabbia, e che sono due manifestazioni della stessa cosa; al pianto, e di questo pianto, pianto continuo soffre anche Selin in una parte di Aut Aut: la madre, che come nella realtà è medico, le dà il riferimento di uno psichiatra e le dice di farsi prescrivere dei farmaci.
Sull’autobiografia, l’autofiction e il memoir, che sono le uniche forme di scrittura che pratica (anche gli articoli lunghi sono personal essay o essay che partono o si collegano a riflessioni personali), le riferisco che poche settimane fa ho letto questa espressione di un giovane giornalista italiano: «Cadere nel memoir». Del tipo «questa scrittrice non è caduta nel memoir, brava» – a me ha fatto pensare alle fallen heroines, le eroine rovinate. Il memoir rovina una scrittrice come il sesso fuori dal matrimonio rovinava le signorine del primo Novecento. Elif Batuman, che è molto posata, gentile e pacata, a sentire la parola fallen fa un deciso dismay hand gesture, e si collega a un ragionamento più ampio: «Come se la scrittura autobiografica fosse più facile – non lo è – o pigra, rispetto al romanzo. Ma è una prospettiva superata, che si basa sulla teoria che si possa separare perfettamente la scrittura in due categorie: quella guidata dalle idee, in cui includono anche il romanzo puro, e quella guidata dal sentimento. Il lavoro più originale che unisce l’esperienza personale e gli eventi del mondo è spesso portato avanti da autrici donne», – mi fa l’esempio di Isabel Wilkerson e del recente film Origin di Ava DuVernay, che è un adattamento del suo libro Caste. Le origini del nostro scontento – «perché le donne sono portate in modo meno violento dalla società a separare la vita emozionale dall’intelletto».
Lei questo continuo spostamento di prospettiva, dallo scrivere del mondo reale in tempo quasi reale, pubblicando varie volte l’anno, allo scrivere romanzi intimistici in prima persona pubblicati ogni sei, sette anni, lo conosce bene. Conosce bene la tentazione costante di rientrare nel mondo delle idee e della realtà, che garantisce un minimo di potere istituzionale (in genere la scrittura giornalistica è inserita in un’organizzazione più grande di noi, come un giornale, o anche solo una piattaforma come Twitter) e un riconoscimento gerarchico, cioè una validazione da persone che stanno più in alto di te in una gerarchia di potere (mi viene in mente la scala naturae aristotelica citata in termini femministi dalla filosofa Chiara Bottici). E poi c’è il brivido di essere nella conversazione attuale, mentre scrivendo romanzi autobiografici in prima persona si cade nella fallace percezione che non c’è fretta, e a nessuno importa quando finisci e il tempo non importa. Le dico che proprio questo fatto che nessuno aspetta il mio libro mi ammazza, e lei mi dice che nessuno aspetta nemmeno il suo, mai, e che non ha ancora trovato il sistema definitivo per rimettersi a scrivere i libri. Ma mi parla di Proust, che ha riletto proprio durante la scrittura di Aut Aut, e di come nonostante fosse interessato all’affare Dreyfus si sia ritirato invece a scrivere libri sulla sua infanzia. È un ritiro solo apparente perché in quei libri poi è finito incapsulato lo spirito del suo tempo e hanno inciso sul reale.
Selin detesta i libri di Proust che deve leggere, in particolare non capisce perché qualcuno mai voglia scrivere della propria infanzia, del passato; così mette in scena il concetto di vergogna per l’infanzia che è molto caro a Batuman. Nasconde la vergogna di chi si era un tempo e quella di essere stati inermi; anche questo sentimento le ha impedito di riprendere il libro sui suoi anni universitari, un sentimento che solo la terapia ha sanato: «Anche se non è molto interessante parlare di terapia, è quello veramente che fa la differenza. Dal punto di vista politico, tutte le gerarchie hanno inizio dalla relazione adulto-bambino, e visto che viviamo in adorazione del potere, ci vergogniamo di essere stati quella creatura completamente impotente. E io sentivo la vergogna assoluta, in modo non mediato. Ora se penso all’argomento non provo più vergogna, lo trovo solo triste e ingiusto». Si collega al discorso sull’imperialismo e post colonialismo, e a come tutte queste gerarchie siano onnicomprensive: «Questo è il discorso che mi era sembrato ingiusto leggendo Orientalismo di Edward Said, al college. Dice che l’occidente infantilizza l’oriente, lo femminilizza, lo rende qualcosa che dev’essere solo ammirato dominato, sfruttato penetrato. Ma in nessun punto del libro dice qualcosa come “e a proposito, queste sono cose che non si devono fare neanche alle donne e ai bambini”».
C’è un passaggio in Aut Aut, autobiografico come il resto, sui corsi di scrittura creativa: «A quanto pareva, scrivere di quello a cui già stavi pensando non era creativo, e non era nemmeno scrittura. Era “ombelicale”. Essere ossessionati dalle proprie esperienze di vita era infantile, egocentrico, non artistico e meritevole di disprezzo». Selin, come la sua autrice, vuole scrivere per comprendere meglio la propria realtà. Ma le scuole di scrittura le chiedono di inventarsi personaggi strani che abbiano «un cibo e un colore preferito». Elif Batuman attribuisce molto della decisione di riprendere in mano L’Idiota al fatto che l’autofiction veniva sdoganata in America proprio attorno a quel periodo, con Ben Lerner e Sheila Heti. A quel punto aveva letto Karl Ove Knausgård e moltissimi altri, tra cui Ferrante che annovera spontaneamente in questo tipo di scrittura, e i tempi erano maturi per quello che voleva fare. «Penso di nuovo che sia una questione politica. Parte della spinta che ho verso la scrittura autobiografica è sentire che le storie che ci sono là fuori non sono accurate, che la realtà viene cambiata per renderla una storia migliore e per molti altri motivi, come proteggere i propri genitori e non lavare i panni sporchi in pubblico. E questo rinforza il senso di vergogna, perché in realtà quello che ci succede davvero crescendo succede a tutti. Ma se ci mettiamo a copiare i tropi delle serie tv, con l’evento come scena madre… Ora per esempio sto cercando di scrivere di relazioni ripetitive, e la convenzione vorrebbe che le astraessi e le rendessi una sola relazione. Ma se la cosa importante di un evento invece fosse proprio che si è ripetuto mille volte?». È l’ossessione per la scrittura cinematografica, mi pare, che incidentalmente è anche quella che insegnano nelle scuole di scrittura – che ha impoverito la letteratura, non l’autofiction.
Anche Proust, mi dice, in Alla ricerca del tempo perduto parla di qualcuno a cui viene impedito di scrivere il libro che deve scrivere («The book that they should write», un concetto che torna molte volte nelle parole di Batuman durante la nostra conversazione).
E la cosa che glielo impedisce sono le tentazioni o distrazioni, fra cui annovera anche l’amicizia, qualsiasi cosa che ti porti al di fuori, verso gli altri. Mi racconta dell’Accademia americana di Roma, di cui è ospite fellow per sei mesi, in cui viene richiesto di fare pranzo e cena insieme agli altri. «Ma non si può, almeno io non posso, lavorare con questi intervalli di socialità intensa nel mezzo. Però allo stesso tempo, c’è un meccanismo evolutivo che ci porta a desiderare di essere parte di una comunità, altrimenti moriremo da soli. È una voce che va ascoltata ma superata».
Elif Batuman ha scritto di imperialismo e di letteratura russa nell’essay Letter from Tblisi (New Yorker), dove espone un punto di vista originale sulla questione “espansionismo russo nella letteratura” e la questione molto attuale delle idee che i libri contengono: «Mi ero istintivamente rifugiata nell’idea che i romanzi dovrebbero essere letti in modo oggettivo. Ma cosa costituiva un atteggiamento oggettivo verso Dostoevskij? (…) Se i libri che avevo amato così oggettivamente erano stati veicolo dell’ideologia patriarcale, perché non avrebbero dovuto contenere anche l’ideologia espansionista?». Del resto Batuman non si sottrae al compito di fornire risposte (prima avevamo citato Isabel Wilkerson: «I don’t write the questions. I write the answers»). Ma nella serie di Selin, che è narrativa, ha creato una voce che fa solo domande – del resto «non sa niente, è una bambina» – e Selin è bravissima a fare domande. Domande che sono così sincere da sembrare in alcuni casi aderire con i punti di vista superati del 1995. Per questo l’autrice ha chiesto la lettura di una «sensitivity reader». «Le ho detto: è un libro su una persona che introietta un sacco di idee tossiche, ma voglio sapere se c’è qualcosa che disturba proprio al punto di mettere giù il libro. Mi ha rimandato moltissimi punti sensibili, ma soprattutto un’intera pagina in cui Selin dice che l’orgasmo clitorideo non è il vero orgasmo e la cosa più completa è quello vaginale. E la lettrice mi ha scritto una pagina contro quest’idea, e diceva ‘non sono d’accordo e non capisco perché il personaggio pensi questa cosa’. Ed è stupendo no? Che non sappia da dove venga quest’idea. Il mondo sta davvero cambiando». Il passaggio, naturalmente, è rimasto.